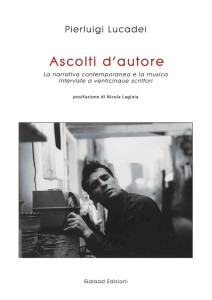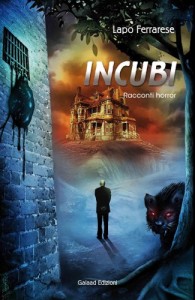Per Capote non si trattava di sabotare il romanzo impegnandosi nell’elaborazione di una forma di racconto in grado di sottrarsi alle maglie di quel genere letterario, ma di raggiungere l’obiettivo opposto: conquistare territori nuovi per la tradizione romanzesca. Il motivo è presto chiarito: dal suo punto di vista, il romanzo in sé, o almeno quello che metta a frutto l’eredità dei capisaldi del naturalismo ottocentesco, non procede alla finzionalizzazione – ossia alla falsificazione in chiave estetizzante – del reale, giacché risulta invece lo strumento cognitivo meglio capace di misurarsi col “particolare” per cogliervi, in maniera quando scoperta e quando indiretta, il riflesso dell’“universale”, o ad ogni modo per ricavare da una scrupolosa rivisitazione della cronaca un accertamento, implicito o esplicito, di una più articolata, e magari rimossa, verità storica. Così, nel capolavoro dello scrittore statunitense, ci ricorda ancora Gigliola Nocera, «tra un indizio di sangue e un altro, tra i mille rivoli di una violenza “localistica”, si fa strada una più globale visione della storia» che, ripensando i «modelli archetipici del gotico americano», intende ribadire «l’irrazionale imprevedibilità degli eventi» e denunciare «l’ennesimo fallimento dell’American Dream».
Per Capote non si trattava di sabotare il romanzo impegnandosi nell’elaborazione di una forma di racconto in grado di sottrarsi alle maglie di quel genere letterario, ma di raggiungere l’obiettivo opposto: conquistare territori nuovi per la tradizione romanzesca. Il motivo è presto chiarito: dal suo punto di vista, il romanzo in sé, o almeno quello che metta a frutto l’eredità dei capisaldi del naturalismo ottocentesco, non procede alla finzionalizzazione – ossia alla falsificazione in chiave estetizzante – del reale, giacché risulta invece lo strumento cognitivo meglio capace di misurarsi col “particolare” per cogliervi, in maniera quando scoperta e quando indiretta, il riflesso dell’“universale”, o ad ogni modo per ricavare da una scrupolosa rivisitazione della cronaca un accertamento, implicito o esplicito, di una più articolata, e magari rimossa, verità storica. Così, nel capolavoro dello scrittore statunitense, ci ricorda ancora Gigliola Nocera, «tra un indizio di sangue e un altro, tra i mille rivoli di una violenza “localistica”, si fa strada una più globale visione della storia» che, ripensando i «modelli archetipici del gotico americano», intende ribadire «l’irrazionale imprevedibilità degli eventi» e denunciare «l’ennesimo fallimento dell’American Dream».
Intervista a Pierluigi Lucadei – “Miracolo italiano” RadioRaiDue
“Letture d’autore” al GR di Radio Rai 1
[audio mp3="https://www.galaadedizioni.com/galaadcafe/wp-content/uploads/sites/3/2016/12/gr1radiorai9dicembre2016.mp3"][/audio]
Al GR di Radio Rai 1, Francesco D'Ayala intervista Pierluigi Lucadei
Wayward Pines, mistero fra i pini
Da “Sguardo Serial” di Andrea Cinalli – Galaad Edizioni 2016
Una piccola comunità di provincia. Grumi di case malandate. Vecchi decrepiti che arrancano abbarbicati ai loro bastoni, sotto un sole che non scalda più. Auto che rombano solitarie su strade dissestate. Negozianti sull’orlo del fallimento che scrutano le vie nella speranza di indurre i viandanti, con la forza del pensiero, a fare acquisti nella loro bottega. Nulla di tutto ciò basterebbe ad accendere espressioni di stupore. Ma che accadrebbe se al nostro passaggio realizzassimo che tutti gli occhi sono puntati su di noi? È quanto accade all’agente speciale Ethan Burke (Matt Dillon). Mentre col partner perlustra la fitta boscaglia, alla ricerca di nuove piste nelle indagini che stanno conducendo per il Federal Bureau, l’auto va a cozzare contro un mastodontico tir materializzatosi nella foschia. Poco dopo, Burke schiude gli occhi nella luce asettica di una stanza d’ospedale. Osserva guardingo l’ambiente, finché una compita infermiera non sopraggiunge a somministrare sedativo e scampoli di informazioni: si trova a Wayward Pines. Burke reclama gli effetti personali, ma con una scusa vacillante – che tuttavia basta ad annientare le sue resistenze – viene quietato senza che possa allertare famigliari e colleghi. Le scusanti si ammonticchiano in una mole spropositata che emana l’olezzo della menzogna finché Burke, addestrato a fiutare l’inganno, arpiona gli indumenti e sguscia via. Zoppicante, si butta fra le vie della cittadina, incurante dei passanti che scartano di lato e lo guardano in cagnesco. Guadagna l’ingresso dell’ufficio dello sceriffo, ma si imbatte in un individuo lardoso che fra le labbra tumide si rigira chewing-gum e pettegolezzi. Chiede di essere accolto dal capo e quando questi acconsente si ritrova al cospetto di un fighetto strappato dal mondo del rap e trapiantato in una plumbea realtà provinciale, con la punta della lingua che tormenta forsennatamente un cono gelato semi-disciolto. Alla richiesta di riavere le sue cose, viene mitragliato di domande sull’incidente. Col tanfo dell’inganno che si è fatta puzza insostenibile, Burke monta a bordo di un’auto lasciata incustodita e avvia la sua fuga dalla cittadina stramba e grottesca. Ma quando la via imboccata conduce al punto di partenza, il poliziotto capisce di essere in trappola. Nessuna via di scampo. Nessuna possibilità di contatto col mondo esterno. Solo il fievole supporto di una vecchia fiamma, ingabbiata nella parte di devota mogliettina assegnatale da chissà chi. E una barista che subito gli si accosta come adiuvante chiarendogli che, una volta in città, ti appioppano una nuova identità e ti sorvegliano affinché ti comporti nel modo prescritto. Trama bella arzigogolata, quella di Wayward Pines, partorita da Blake Crouch. Il giovane romanziere, che ne ha sviluppato una trilogia letteraria di successo prima di meditare su una trasposizione televisiva, passeggiava per le vie di una località della Columbia cinta da vette innevate, le mani allacciate dietro la schiena e la quiete notturna rotta solo dal guaito di qualche solingo cagnetto, quando è fioccato il primo barlume di idea. “Cosa accadrebbe se restassi bloccato qui, se non potessi tornare a casa?”, una di quelle domande che molti relegherebbero in un anfratto della mente, liquidandola come il timore infondato di un vacanziero abituato alle ansie del tran-tran. Ma lui – da scrittore – ci ha ricamato su. L’ha assaporata finché a ogni aroma non è riuscito ad attribuire un volto e una storia. Ad affiancare Crouch nell’adattamento televisivo è Chad Hodge. Fu lui a scoprire lo script di American Beauty, poi baciato da un successo di critica e pubblico suggellato dalla vittoria agli Oscar. Alla guida della crew di Wayward Pines è arrivato dopo un filotto di incarichi analoghi in Veritas, Tru Calling, Runaway. In Fuga e The Playboy Club. A dispetto dei paragoni con Twin Peaks, Wayward Pines non è sorretta dalla stessa cura per personaggi e ambientazione. L’intenzione di edificare un impianto narrativo che imitasse le impalcature da prodotto cable è subito evidente, a partire dall’ordine di una midseason di dieci episodi, che non in neschi l’effetto sbadiglio delle maestose stagioni di ventidue ore da broadcast tv. Fa il verso alla tessitura cable anche la narrazione a incastro: le turbolente vicende del presente sono interrotte da sequenze che accennano a un passato remoto e nebuloso. Wayward Pines manifesta insomma la voglia di ergersi a cult, di dominare l’olimpo delle grandi serie e rilucere di costruzioni narrative che appena si intravvedono nel pilot. Ma per ora sembra alta la possibilità che la serie – dopo appena una stagione – venga offuscata dalla variegata offerta televisiva elargita in estate. E che passi via come la brezza che scuote i pini attorno alla città.
Sulla crisi della critica
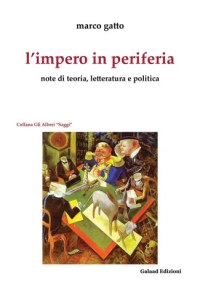 La questione della crisi della critica letteraria e culturale sembra essersi arenata su una sorta di indisturbata concordia, dopo il profluvio di libri, saggi, interventi e opuscoli pubblicati a partire dai primi anni Novanta. È pacifico, per i più, che la critica abbia un suo posto ben delimitato nella società odierna; e allo stesso modo è pacifico che, proprio sulla scorta di tale posto infine ironicamente conquistato, la critica – e la sua mancata funzione civile – finisca per essere un elemento caratterizzante il nostro tardo capitalismo o, meglio, un elemento assorbito da, e funzionale a, quest’ultimo. D’altra parte, per restare nel nostro Paese, sono almeno vent’anni che il dibattito sui metodi e sulle tecniche della critica langue. Tanto che gli strumenti dello studio letterario sono ancora fermi ai retaggi dello strutturalismo e della linguistica come modello applicativo nell’analisi dei testi. Basti aprire una qualsiasi rivista di italianistica o leggere i titoli delle tesi di dottorato. Romano Luperini ha ben evidenziato, in molti dei suoi contributi, la scissione tutta italiana (perché, obiettivamente, esiste un “caso” peninsulare) tra una critica interessata al dettaglio, legata ai territori della microfilologia, prigioniera della presunta “letterarietà” del testo e di tutti i miti della falsa esternalità della letteratura; e una critica, dall’altra parte, praticata col mezzo dell’empatia e con il fine del narcisismo volontario, in cui il giudizio è affidato alle viscere più che all’intelletto, senza tacere la presunzione di volersi, il critico, sostituire allo scrittore. È forse quest’ultima pratica, che affolla le pagine culturali dei nostri quotidiani o persino le televisioni, ad atterrire più del resto. Perché, dall’assenza di un dibattito sui metodi, e per causa di un ritorno romanticheggiante alla “bellezza” del testo, quest’ultima critica ha assunto la possibilità di crearsi una propria legittimazione, un proprio codice e un proprio linguaggio. I critici-narcisi, in Italia, non sono una distorsione del sistema, bensì il crisma della sua vitalità; sono oggi, insomma, un gruppo capace di estendere la propria egemonia, attraverso l’occupazione dei mezzi di stampa e la diffusione di un manierismo che si fonda sul culto del gusto e sull’apologia dell’individuo capace, più di altri, di gustare l’arte, senza perdere il tempo di scendere nell’arena del dibattito e dell’argomentazione, senza capirla davvero.
La questione della crisi della critica letteraria e culturale sembra essersi arenata su una sorta di indisturbata concordia, dopo il profluvio di libri, saggi, interventi e opuscoli pubblicati a partire dai primi anni Novanta. È pacifico, per i più, che la critica abbia un suo posto ben delimitato nella società odierna; e allo stesso modo è pacifico che, proprio sulla scorta di tale posto infine ironicamente conquistato, la critica – e la sua mancata funzione civile – finisca per essere un elemento caratterizzante il nostro tardo capitalismo o, meglio, un elemento assorbito da, e funzionale a, quest’ultimo. D’altra parte, per restare nel nostro Paese, sono almeno vent’anni che il dibattito sui metodi e sulle tecniche della critica langue. Tanto che gli strumenti dello studio letterario sono ancora fermi ai retaggi dello strutturalismo e della linguistica come modello applicativo nell’analisi dei testi. Basti aprire una qualsiasi rivista di italianistica o leggere i titoli delle tesi di dottorato. Romano Luperini ha ben evidenziato, in molti dei suoi contributi, la scissione tutta italiana (perché, obiettivamente, esiste un “caso” peninsulare) tra una critica interessata al dettaglio, legata ai territori della microfilologia, prigioniera della presunta “letterarietà” del testo e di tutti i miti della falsa esternalità della letteratura; e una critica, dall’altra parte, praticata col mezzo dell’empatia e con il fine del narcisismo volontario, in cui il giudizio è affidato alle viscere più che all’intelletto, senza tacere la presunzione di volersi, il critico, sostituire allo scrittore. È forse quest’ultima pratica, che affolla le pagine culturali dei nostri quotidiani o persino le televisioni, ad atterrire più del resto. Perché, dall’assenza di un dibattito sui metodi, e per causa di un ritorno romanticheggiante alla “bellezza” del testo, quest’ultima critica ha assunto la possibilità di crearsi una propria legittimazione, un proprio codice e un proprio linguaggio. I critici-narcisi, in Italia, non sono una distorsione del sistema, bensì il crisma della sua vitalità; sono oggi, insomma, un gruppo capace di estendere la propria egemonia, attraverso l’occupazione dei mezzi di stampa e la diffusione di un manierismo che si fonda sul culto del gusto e sull’apologia dell’individuo capace, più di altri, di gustare l’arte, senza perdere il tempo di scendere nell’arena del dibattito e dell’argomentazione, senza capirla davvero.
(da L’impero in periferia, Marco Gatto, Galaad Edizioni 2015)
Fracking
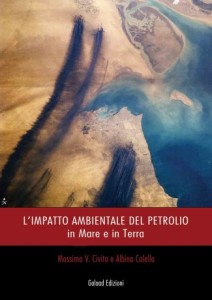 Fracking è un’abbreviazione di hydraulic fracturing o fratturazione idraulica. Secondo l’USEPA (U.S. Environmental Protection Agency) il fracking è un processo di stimolazione di un pozzo di gas, di petrolio o di energia geotermica per massimizzare l’estrazione. Si tratta di un metodo frequentemente usato in giacimenti non convenzionali per migliorare la produzione di gas naturale in argille più o meno diagenizzate (shale gas). Il fracking consiste nell’iniezione ad alta pressione nel sottosuolo di grandi quantità di fluidi e di altri materiali, al fine di fratturare le rocce e liberare gli idrocarburi presenti. Dopo che il pozzo è stato perforato, ad una certa profondità la trivella viene direzionata orizzontalmente e l’alta pressione dei fluidi innesca una serie di microsismi che frantumano la roccia, lasciando sprigionare gli idrocarburi ivi contenuti.
Fracking è un’abbreviazione di hydraulic fracturing o fratturazione idraulica. Secondo l’USEPA (U.S. Environmental Protection Agency) il fracking è un processo di stimolazione di un pozzo di gas, di petrolio o di energia geotermica per massimizzare l’estrazione. Si tratta di un metodo frequentemente usato in giacimenti non convenzionali per migliorare la produzione di gas naturale in argille più o meno diagenizzate (shale gas). Il fracking consiste nell’iniezione ad alta pressione nel sottosuolo di grandi quantità di fluidi e di altri materiali, al fine di fratturare le rocce e liberare gli idrocarburi presenti. Dopo che il pozzo è stato perforato, ad una certa profondità la trivella viene direzionata orizzontalmente e l’alta pressione dei fluidi innesca una serie di microsismi che frantumano la roccia, lasciando sprigionare gli idrocarburi ivi contenuti.
Il fracking richiede una grandissima quantità d’acqua, proppanti (generalmente sabbia silicea, particelle ceramiche e altri materiali) per tenere aperte le fratture della roccia e favorire la fuoriuscita degli idrocarburi, e additivi di vario tipo. Per la fratturazione mediamente sono richiesti: 88% di acqua, 10% di sostanze quarzose (proppanti), 2% di additivi per lo più chimici (SUCHY & NEWELL, 2011; USEPA, 2015; fracfocus.org/).
I principali impatti che le operazioni di fracking possono produrre sono:
O Attività sismica del sottosuolo e probabile liquefazione in aree soggette.
O Incendi ed esplosioni.
O Dispersione in aria di inquinanti.
O Contaminazione di acque superficiali e sotterranee.
O Produzione di scarti.
O Sollevamento di polveri e produzione di scarti e residui da opere civili.
O Distruzione paesaggistica a causa degli impianti di produzione e delle opere di collegamento.
(da L’impatto ambientale del petrolio, Massimo V. Civita e Albina Colella, Galaad Edizioni 2015)
https://www.galaadedizioni.com/limpatto-ambientale-del-petrolio/
Il sentiero e il ragazzo del granturco (Gabriel Miró)
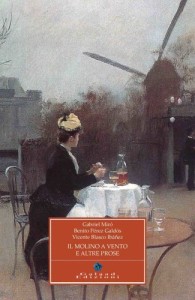 “Il sentiero e il ragazzo del granturco” di Gabriel Miró (da Il molino a vento e altre prose, Gabriel Miró – Benito Pérez Galdós – Vicente Blasco Ibáñez, traduzione di Riccardo Ferrazzi e Marino Magliani, Galaad Edizioni 2015)
“Il sentiero e il ragazzo del granturco” di Gabriel Miró (da Il molino a vento e altre prose, Gabriel Miró – Benito Pérez Galdós – Vicente Blasco Ibáñez, traduzione di Riccardo Ferrazzi e Marino Magliani, Galaad Edizioni 2015)
Un ragazzino porta in spalla un sacco di fu-sti di granturco e pannocchie che già mostrano i grani.
Viene per un sentiero calcareo, riarso e sconnesso. Lo percorre approfittando dell’ombra dei giardini: va su e giù costeggiando muri felpati di funghi, licheni color bronzo o terra di siena, recinti di pietra viva, freschi muri di terra, spigoli di calce; e pendono i roseti, l’edera, le viti rampicanti; si affacciano i fichi, che spandono l’odore latteo del tronco e dei tralci; una palma contorta che si stiracchia; la cupola di un arancio; le arcate di un mirto monumentale; immobili cactus in grandi vasi; siepi di bosso merlate. Un cipresso dall’aria claustrale è come un indice posto in croce sulle labbra dei giardini perché tutto taccia, tranne l’acqua, le fronde, le api, gli uccelli, le ore suonate dai campanili che nuotano nell’azzurro, il canto dei galli, i passi dei viandanti, i voli delle colombe. Tutto tace, tranne il silenzio.
I giardini, oltre alle porte e ai cancelli principali, hanno una porticina intima e umile, con una scaletta a ponticello sul fosso a lato del sentiero. Di lì esce il proprietario, lì bussano e aspettano i mendicanti.
Anche il ragazzino del granturco si ferma. Una di queste porticine è aperta, ci sono bambini che giocano, ridono, fanno amicizia.
Questo sentiero è così bello che perfino i padroni dei giardini, ogni tanto, vengono qui, dietro i contrafforti di terra, per vederlo. Se lo guardano ben bene, approvano, sorridono delicatamente come se facessero o permettessero qualcosa di buono. Che delizia essere buoni! Fanno fatica a capire che gli altri non hanno un giardino come il loro, con un sentiero come questo, scorticato, ardente e scavato fra muri freschi e bastioni nitidi, abbaglianti.
I bambini del giardino hanno fatto entrare il ragazzino del granturco. Hanno fatto amicizia, le spalle del ragazzo odorano di fune di sparto, la sua camicia sa di sudore, di foraggio e di pannocchie con grani teneri e bianchi come denti di un bambino.
Lungo il sentiero si avvicina un viandante. Per un bel po’ si sentono i passi delle sue scarpe di corda; lo si ascolta fermarsi a guardare il sentiero, la distanza ancora da percorrere. Il sole, lo sfondo azzurro, e in mezzo una gloriosa nube bianca.
Tranquillità dei giardini a mezzogiorno. Voglia di chiedere al viandante se va molto lontano, e dopo averlo visto e ascoltato, dài che ce la fai, dài che arriverai!
I bambini tacciono e si guardano con diffidenza.
Un uomo scende rapidamente lungo il sentiero, si sente un crocchiare di documenti arrotolati. Torna in paese, e ha pensato: passo di qui e risparmio un po’ di strada. Quell’uomo indaffarato vede in quel tratto di strada, addormentato come l’acqua di un canale romantico, solo una scorciatoia; pare quasi che sia lui ad aprirla, con la sua fretta.
I bambini litigano, e non c’è più modo di rappacificarli.
Il ragazzino del granturco corre alla portici-na del giardino. Gli altri lo rincorrono fino a una vite che si arrampica sul muro e gli gridano: «Adesso noi giocheremo con un elefante che, se glielo dici, lui con la proboscide pren-de l’indiano e se lo mette in groppa…».
«E con un piroscafo che attraversa da solo tutta la vasca. Tutta la vasca!»
Il ragazzino del granturco si volta: «E io vado a casa mia a mangiare una pannocchia cotta al forno!».
Quelli del giardino si eccitano ancor di più, fanno salti, si chiudono le orecchie con i palmi delle mani e ridono e gridano: «Ma come! Noi non l’abbiamo sentito e tu sì!».
E scendono dal bastione, frignano, e chie-dono pannocchia arrostita, pannocchia arrostita…
Figli della Resistenza
di Antonio Tricomi
Chi sono e come lavorano, grossomodo nel primo trentennio dell’Italia Repubblicana, quelle particolari figure di romanzieri, poeti e saggisti che Romano Luperini (cfr. Controtempo. Critica e letteratura fra moderno e postmoderno: proposte, polemiche e bilanci di fine secolo, Liguori, Napoli 1999, pp. 173-175) e Marco Belpoliti (Settanta, Einaudi, Torino 2001, p. IX) hanno definito, rispettivamente, «scrittori-intellettuali» e «intellettuali-scrittori»? E cosa ha voluto dire, in quello stesso periodo, proporsi alla comunità dei lettori nelle vesti di critici letterari militanti?
Sono anzitutto i principali autori nati a ridosso o nel pieno degli anni Venti dello scorso secolo a corrispondere alle de-scrizioni offerteci da Luperini e Belpoliti: per fare appena qualche nome, si sta parlando di Fortini, Pasolini, Calvino, Bianciardi, Volponi, Sciascia, Zanzotto, Primo Levi. Al pari dei loro coetanei, questi e gli altri scrittori appartenenti alla medesima generazione si sono formati nelle scuole del regime; hanno dovuto compiere, in gioventù, la scelta epocale di essere fascisti o antifascisti; se non sono stati partigiani, hanno spesso vissuto, a guerra finita, il senso di colpa di non esserlo stati. E, dopo la Liberazione, molti fra loro si sono via via candidati ad essere le coscienze critiche della nuova so-cietà democratica, della quale, prendendo la parola in pubblico, hanno costantemente additato i ritardi e alla cui costruzione hanno cercato, con i propri testi, di collaborare. In ossequio alla lezione di molti capolavori e maestri della modernità, le loro opere nascono infatti pressoché sempre al confine tra narrativa, poesia, saggistica e con l’intento di ibridare tali generi letterari e discorsivi per meglio proporsi ai lettori quali esplicite ricognizioni o come allegoriche rivisitazioni del presente e della storia; e la loro più profonda identità di autori è perciò quella di critici della cultura a tutto campo, generalmente molto severi con i processi di modernizzazione in atto nell’Italia del dopoguerra o comunque capaci di cogliere il lato oscuro del boom economico e le contraddizioni insite nei vari progetti di emancipazione collettiva.
Ciascuno a proprio modo, Fortini e Volponi, Pasolini e Calvino sono insomma umanisti che, in virtù di questa loro formazione e dell’intrinseco valore civile ad essa riconosciuto, ambiscono a presentarsi come “intellettuali-legislatori”. A sospingerli è il desiderio di misurarsi con le “grandi narrazioni”, per accoglierle o rigettarle, e dunque altresì la volontà di interloquire con i gruppi politici e i Partiti di massa che simili orizzonti socioculturali veicolano, come pure – ovviamente – l’ansia di raggiungere quei lettori che agli esiti di un analogo confronto e ai risultati del medesimo dialogo affidano la definizione della propria identità civica. Agli occhi di tali scrittori, la letteratura è quindi uno strumento socialmente irrinunciabile: essa s’incarica di “testare” e aspira a rinvigorire la dialettica democratica, della quale intende anche denunciare le ipocrisie per poi impegnarsi nella costante elaborazione di utopie civili.
Né i primi decenni di storia repubblicana hanno in fondo visto lavorare in maniera differente i cosiddetti critici militanti. I migliori e i più consapevoli fra loro si sono infatti parimenti proposti come intellettuali-legislatori, poiché non hanno giudicato i libri esclusivamente in base al proprio gusto personale, ma hanno compiuto sforzi di pur discutibile oggettivazione culturale al cospetto di prodotti sempre liberamente sindacabili da ciascun fruitore quali quelli estetici. In altre parole, quanti esercitavano la critica militante miravano a vagliare le opere contemporanee e gli esiti della tradizione appoggiandosi a metodi interpretativi che risultavano il trait d’union tra quei testi e una varietà di saperi comunitari, identità condivise, istituzioni, gruppi sociali, formazioni politiche che agli esegeti professionisti chiedevano di svelare la coincidenza o la minima distanza o l’insanabile frattura tra le proprie idee di società e quella propugnata, magari indirettamente, da ogni singolo libro sondato. Così, la critica militante ha cercato d’essere l’anello di congiunzione tra le “grandi narrazioni”, finché la storia non le ha spazzate via, e la letteratura, nel senso che ha decifrato gli esiti e l’evoluzione della seconda con i criteri e in considerazione degli obiettivi delle prime. Scelta a tratti anche conformistica, o persino normalizzatrice, giacché incline a promuovere o bocciare un testo magari semplicemente in base alla sua compatibilità, oppure no, con peculiari forme di ortodossia ideologica. Ma anche scelta assai utile a quegli scrittori, e a quei lettori, che attraverso il confronto con un’esegesi comunque orientata potevano acquisire ulteriore coscienza delle proprie poetiche, gli uni, o della loro cifra culturale, gli altri.
(da “Nessuna militanza, nessun compiacimento” di Antonio Tricomi (Galaad Edizioni 2014))
www.galaadedizioni.com/nessuna-militanza-nessun-compiacimento/
“Ascolti d’autore” di Pierluigi Lucadei – La videorecensione di Luigi Mascheroni
Se gli scrittori le cantano belle ai musicisti… clicca qui per vedere la videorecensione
I cantautori? Bravi musicisti, ma non certo poeti. I libri scritti dalle rockstar? Un modo per fare soldi e basta. La top five degli album più belli di tutti i tempi? Ognuno, ovviamente, ha la sua… Se amate la musica e la letteratura allo stesso modo, ecco il libro per voi: “Ascolti d’autore” (Galaad edizioni) in cui il giornalista e critico musicale Pierluigi Lucadei ha raccolto 25 interviste a grandi scrittori italiani e stranieri, da Niccolò Ammaniti a Michael Chabon, da Hanif Kureishi a Ingo Schulze, da Will Wiles a David Leavitt. Che, parlando di rock, classica e jazz, ci svelano, fra (dis)gusti, curiosità e invidie, i meravigliosi rapporti tra musica e letteratura.
“Incubi” – Lapo Ferrarese
di Roberto Ruggieri
Per un appassionato di narrativa horror, lettore sufficientemente avvezzo alle trame, alle entità, alle visioni raccontate in maniera pregevole dai più noti scrittori del genere, “Incubi” rappresenta un territorio dal paesaggio familiare ma non ancora realmente visitato. Tracce, ricordi sfumati, accennati deja vu provenienti dalla più nota produzione letteraria del terrore, emergono, ma senza eccessiva evidenza e sicuramente senza alcuna imitazione, tra le righe dei tre racconti nati dalla fantasia del quasi debuttante lapo ferrarese. L’ansia, il brivido e il mistero di Stephen King; la crudezza, il ritmo incalzante e l’introspezione dei personaggi alla Dean Koontz; l’impalpabilità delle entità, la fantasia onirica e le atmosfere angoscianti delle storie di Howard Phillips Lovecraft; e così via. Riferimenti che non servono a sostenere che “Incubi” è una commistione di stili e contenuti già letti, ma per evidenziare che, soprattutto oggi, la scrittura horror non può essere improvvisata e deve avere alla base una passione e una “esperienza” che necessariamente si sviluppano grazie alla lettura dei più grandi maestri del genere. Nonostante ciò, i tre racconti devono avere e hanno anche un che di peculiare, di prettamente “Ferrarese”: la capacità di raccontare dei terribili sogni come se chi narra stesse ancora sognando, cioè fosse convinto che tutto stia realmente accadendo. Come in tutti i sogni che si rispettino. E tale “illucidità” onirica coinvolge anche il lettore, il quale non si ritrova ad essere un semplice ascoltatore di un incubo descritto da chi si è appena svegliato, ma diventa compagno di sogno dei personaggi coinvolti e ne condivide la strana e terrificante realtà. Non a caso, quindi, la raccolta delle tre storie di lapo ferrarese ha titolo “Incubi”: che siano mostri, creature mai viste da occhio umano, ambienti mortali, fantasmi o mondi paralleli, tutte le entità sembrano avere origine da sogni, ma sono percepiti come protagonisti reali e tangibili di una realtà che, per quanto incredibile, è lì, di fronte ai nostri occhi; anzi, ci parla, ci tocca, ci uccide. Nei racconti di Ferrarese i personaggi non sanno di essere in un incubo, se incubo è veramente; comunque a nessuno è stato dato il compito di destarli. E il lettore, con loro, rimane intrappolato fino alla fine in questa realtà senza uscita.
(Lapo Ferrarese, Incubi, pp.180, 13,00euro, Galaad Edizioni)